 Quando parliamo di progetti di nuova domiciliarità intendiamo non tanto strutture residenziali quanto piuttosto civili abitazioni, in cui vivono una o più persone che si trovano in una condizione di non completa autonomia o di fragilità e con le quali collaboriamo per coprogettare un servizio di supporto alla domiciliarità. Sono servizi che definiamo leggeri perché prevedono un monte ore settimanale relativamente basso che può raggiungere un massimo di dieci ore settimanali. Sono progetti recenti e quindi, in qualche modo, ancora sperimentali per noi
Quando parliamo di progetti di nuova domiciliarità intendiamo non tanto strutture residenziali quanto piuttosto civili abitazioni, in cui vivono una o più persone che si trovano in una condizione di non completa autonomia o di fragilità e con le quali collaboriamo per coprogettare un servizio di supporto alla domiciliarità. Sono servizi che definiamo leggeri perché prevedono un monte ore settimanale relativamente basso che può raggiungere un massimo di dieci ore settimanali. Sono progetti recenti e quindi, in qualche modo, ancora sperimentali per noi
Al momento questi progetti coinvolgono un totale di 13 persone che abitano 6 appartamenti (4 ad Alba e 2 a Bra). Il gruppo di utenza è molto eterogeneo: ci sono persone che hanno una disabilità lieve; altre con un disturbo di natura psichiatrica; altre ancora appartengono a quelle che chiamiano “fasce deboli”. Alcuni vivono da soli, altri invece condividono l’appartamento; e nelle convivenze abbiamo situazioni in cui il rapporto tra i conviventi è del tipo – da inquilino a inquilino – e altre situazioni dove invece ci sono legami affettivi. Anche la provenienza delle persone, il cui cammino le ha portate verso questo tipo di progettualità, è molto varia. Per alcune di loro il progetto è stato la prosecuzione della scuola di autonomia. Per altri invece l’abitare in autonomia è stato il punto di arrivo di un percorso residenziale che magari è iniziato in una struttura ad alta copertura -le comunità tanto per intenderci – e che si è poi sviluppato nel corso degli anni attraverso passaggi in strutture sempre meno presidiate dagli operatori fino ad arrivare a qui. E quindi parliamo di percorsi piuttosto lunghi. Altri, infine, sono approdati alle nuove domiciliarità per fronteggiare un’emergenza, creatasi perché sono mutate alcune condizioni che hanno comportato l’emergere di fragilità che prima erano in qualche modo compensate.
Tale eterogeneità ci obbliga a pensare e a coprogettare con gli utenti (e la coprogettazione è invece una caratteristica comune a tutti questi progetti) degli interventi altamente flessibili e personalizzati in grado di adattarsi il più possibile ai bisogni – e ai sogni, ai desideri – delle persone con le quali lavoriamo.
A proposito della coprogettazione vorrei raccontare un piccolo episodio vissuto recentemente. Mi trovavo a casa di un utente e stavo discutendo con lui i punti del rinnovo del suo progetto abitativo dato che quello attuale era in scadenza. Dopo aver discusso tutti questi punti allora io gli dico “Bene allora butto giù una bozza di progetto e la giro a te e a tuo fratello ( che è anche il tutore di questa persona) e poi se va bene la condividiamo in un incontro ufficiale”. Lui tutto gentile mi dice che va benissimo così, ci salutiamo e poi dopo un paio d’ore mi chiama al telefono e mi dice: “Senti, sai quando parlavamo prima del rinnovo del progetto. Mi hai detto che ne avresti mandata una copia a me e una a mio fratello…Va bene, però volevo chiederti se potevi inviarla prima a me e poi dopo a lui, per vedere se andava bene…”
 Ecco, in questa situazione la persona ha voluto rivendicare la titolarità del progetto. In qualche modo è come se mi avesse detto: “Va bene che ho un tutore, ma il protagonista sono comunque io!”. Cosa forse scontata, ma non banale.
Ecco, in questa situazione la persona ha voluto rivendicare la titolarità del progetto. In qualche modo è come se mi avesse detto: “Va bene che ho un tutore, ma il protagonista sono comunque io!”. Cosa forse scontata, ma non banale.
L’eterogeneità ci stimola anche a trovare spazi di riflessione condivisi per creare un modello, di intervento, una cultura comune del lavoro con le nuove forme di domiciliarità. Un interrogativo che spesso ci accompagna è quello del dove ci collochiamo all’interno di una dinamica che ci pone tra due punti estremi ideali: da un lato la tutela, nostra, dei servizi, delle persone e dall’altro quello della promozione della massima autodeterminazione. Noi operatori dobbiamo sempre più abituarci ad abitare questo spazio che sta tra una funzione di tutela e una invece di stimolo all’autodeterminazione delle persone e alla promozione delle loro autonomie.
E cosa vuol dire abitare questo spazio? Significa innanzitutto accettare il rischio. Accettare che la persona compia delle scelte che magari noi non condividiamo, che magari ci fanno preoccupare perché sentiamo che potrebbero mettere in pericolo la stabilità raggiunta. La fiducia che ciascuno costruisce in se stesso è anche legata alla possibilità di sperimentare che ci è stata data e alla possibilità di sbagliare, perché autonomia significa anche sbagliare. Quindi dobbiamo abituarci ad una coprogettazione continua che si modifica in base alle scelte delle persone.
Dobbiamo abituarci a tollerare che l’altro può decidere di tenerci al di fuori di tutta una parte della sua esperienza di vita, che non intende per qualche motivo condividere. E quindi dobbiamo abituarci ad abitare anche gli spazi in cui ci sono delle zone nelle quali non ci è permesso di entrare. Un po’ come in adolescenza quando ad un certo punto i genitori sentono che i figli cominciano a non voler condividere più una serie di cose.
Qualche tempo fa, una delle persone con cui lavoriamo ha deciso di ospitare a casa la sua fidanzata. Naturalmente non ci ha chiesto prima il permesso, anzi ha anche provato a nascondere la cosa. Poi visto che tra la roba stesa comparivano reggiseni e altri capi evidentemente femminili qualche domanda ce la siamo posta. Ecco in quella situazione ci siamo trovati a ripensare a tutto il progetto con quella persona, anzi con quelle persone. E abbiamo ricominciato a tessere il filo della relazione e della fiducia, che si era parecchio ingarbugliato. Adesso i due fidanzati continuano a vivere insieme ed è passato quasi un anno e mezzo. Pochi di noi avrebbero scommesso un euro sulla prosecuzione di quella convivenza e invece sono ancora lì. Anzi siamo ancora lì.
 E poi dobbiamo porre le condizioni perché lo spazio tra tutela e autodeterminazione sia abitato anche dalla comunità locale, dal quartiere, dal vicino di casa, dal barista: c’è una lite con il vicino di casa. Intervengo? Lascio che la persona gestisca da sé la cosa? Il barista mi ferma per chiedermi se conosco quella persona che va tutte le mattine nel suo bar per chiedere di avere un caffè a scrocco. Me la prendo io la responsabilità? O cerco di capire se il barista la può risolvere da sé direttamente con la persona?
E poi dobbiamo porre le condizioni perché lo spazio tra tutela e autodeterminazione sia abitato anche dalla comunità locale, dal quartiere, dal vicino di casa, dal barista: c’è una lite con il vicino di casa. Intervengo? Lascio che la persona gestisca da sé la cosa? Il barista mi ferma per chiedermi se conosco quella persona che va tutte le mattine nel suo bar per chiedere di avere un caffè a scrocco. Me la prendo io la responsabilità? O cerco di capire se il barista la può risolvere da sé direttamente con la persona?
Uno dei nostri formatori storici, il professor Paolo Henry insisteva molto sulla necessità di promuovere autonomie che riconoscessero diritti ma anche doveri nelle persone disabili. Autonomia anche nell’assumersi le responsabilità delle proprie scelte per poter rivendicare un sacrosanto diritto di cittadinanza.
Al momento seminiamo dubbi, in futuro vedremo quale tipo di raccolto verrà fuori.
Davide Tedesco
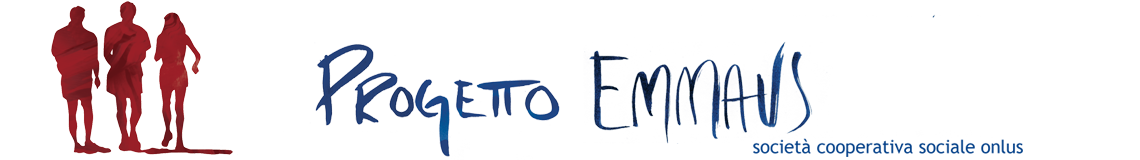
Una risposta a Questa è la mia casa, questo è il mio quartiere. Esperienze di nuove domiciliarità: abitare lo spazio tra tutela e autodeterminazione.